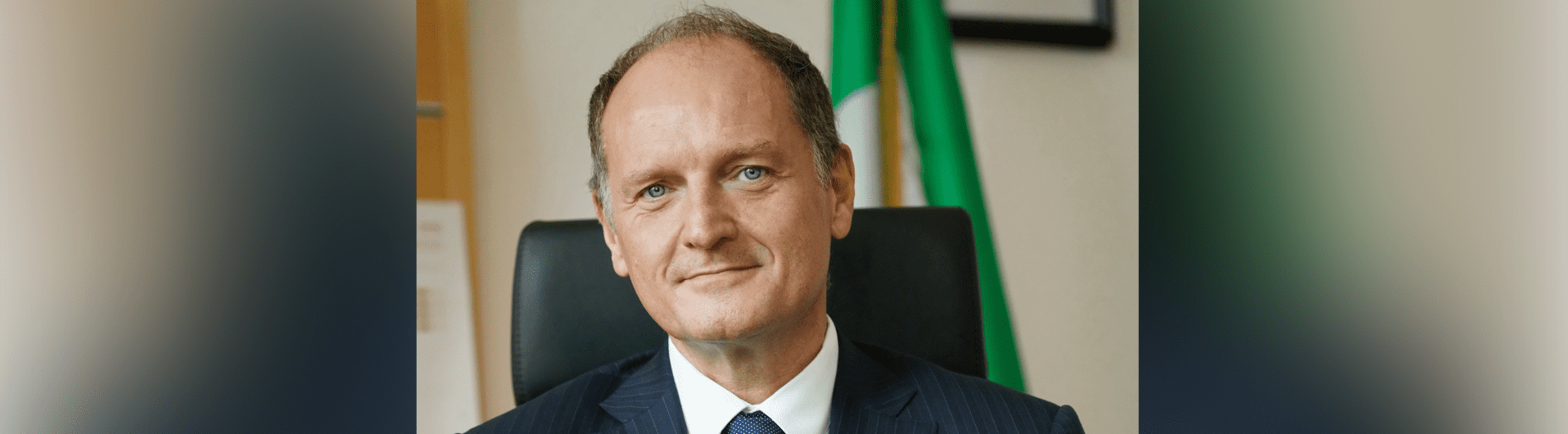23 December 2022
Intervista al Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco
Parliamo con il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, che esplora con noi le opportunità offerte dal PNRR e dalle possibili sinergie tra università e imprese per lo sviluppo di nuove tecnologie per i progetti infrastrutturali.
Il PNRR è destinato a sostenere in maniera rilevante numerosi progetti in campo infrastrutturale. Secondo la sua opinione, quali opportunità si aprono per il nostro Paese?
I fondi in arrivo dal PNRR offrono al Paese opportunità di miglioramento delle infrastrutture viarie e delle infrastrutture associate all’energia, che devono essere ripensate in una prospettiva sostenibile e, al tempo stesso, integrate con altri servizi pubblici. In tal senso, il mio auspicio è che si aprano delle sinergie virtuose nell’erogazioni dei servizi, soprattutto per le aziende multiutility, che oggi hanno la possibilità di trainare il Paese verso il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale. A mio parere, sono proprio queste sinergie di funzioni che nel futuro potranno essere realmente incisive nei settori strategici. Penso, ad esempio, alle comunità energetiche, che possono apportare benefici non solo ai privati cittadini, ma anche alle industrie, per favorire una crescita sostenibile e garantire il controllo dei costi energetici. Il PNRR rappresenta un vero e proprio progetto strategico per il nostro Paese e sicuramente le università possono essere d’aiuto nella sua attuazione, dedicandosi alla Terza Missione, per rafforzare il coordinamento tra il mondo della ricerca, la comunità, le istituzioni e le imprese.
L’Italia è un paese ad alto rischio idrogeologico. Gli investimenti previsti dal PNRR potranno essere realmente incisivi nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico?
A mio parere, purtroppo, non credo sarà possibile effettuare degli interventi incisivi in tempi brevi, perché di fatto si tratta di una lotta contro la natura. Piu che intervenire nelle zone a rischio sarebbe necessario disimpegnarsi da certe aree per ricollocarsi in zone più sicure facendo leva su una progettazione più efficace e integrata, che comprenda lo sfruttamento di nuovi servizi, come le comunità energetiche, e di una nuova edilizia.
Quanto conterà in futuro la sostenibilità nello sviluppo di nuove tecnologie per i progetti infrastrutturali?
Sono fiducioso che la sostenibilità conterà sempre di più, soprattutto perché è ormai nel DNA delle nuove generazioni ed influisce su tutti gli ambiti economici. Le aziende in tal senso devono avere una credibilità dal punto di vista sociale e ambientale, nel rispetto dei principi ESG. Oltre alla sfida ambientale, l’altra sfida che abbiamo davanti è legata al tema delle disuguaglianze sociali, per garantire servizi migliori in uno Stato che diventa imprenditore di se stesso e dei cittadini.
Il Politecnico è un centro di eccellenza a livello nazionale ed internazionale. Secondo il suo punto di vista, quale sarà il contributo dell’Ateneo sul fronte della ricerca e del supporto ai distretti di innovazione in ambito ingegneristico?
Secondo la classifica stilata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il Politecnico di Torino è la prima università in Italia per la qualità dei risultati dell’attività di ricerca, valutati attraverso i casi studio sulle attività di Terza missione. Nell’ambito della Terza missione, l’università può cambiare il modo in cui forma i laureati, favorendo una co-progettazione con le imprese. Per questo è necessario lavorare insieme al tessuto imprenditoriale italiano per creare percorsi di didattica integrata.
Anche la ricerca applicata è fondamentale. Attualmente il Politecnico di Torino ha istituito 16 Centri interdipartimentali, per rendere sistematica la collaborazione interdisciplinare fra i diversi ambiti tecnologici e scientifici. È proprio dalla commistione di diversi saperi e discipline che nascono nuove tecnologie, fortemente legate da un lato ai materiali, all’elettronica, agli algoritmi, piuttosto che alla sostenibilità. Nell’ambito caro a Maccaferri abbiamo istituito un laboratorio che si occupa della stabilità delle infrastrutture, della loro sensorizzazione e della manutenzione predittiva. Insomma, è in questi luoghi che si elaborano risposte molto piu efficaci.
Quanto è importante la collaborazione tra università e imprese per colmare il gap che l’Italia sconta sul fronte delle competenze STEM?
L’origine del divario che l’Italia sconta sul fronte delle competenze STEM è legata ai percorsi formativi pre-universitari. Come Politecnico di Torino, ci stiamo impegnando in azioni di orientamento e contaminazione dei percorsi formativi nelle scuole e nei licei, dove cerchiamo di stimolare riflessioni e dibattiti su temi legati alle tecnologie e determinanti per il futuro della società. Il mutuo coinvolgimento è fondamentale affinché cresca l’attenzione all’esterno. Ad oggi si avverte sempre più la necessità di formare “ingegneri etici”, che progettino tecnologie in modo consapevole e orientate al bene comune. Vi è anche il fenomeno della scarsa partecipazione delle donne alle discipline STEM, collegato al più ampio problema della disparità di genere. La speranza è che la rivoluzione che ha dato sempre più spazio alle discipline Humanities nell’ambito dei percorsi di laurea di ingegneria, spinga le donne ad affascinarsi a questo mondo. In generale, se riuscissimo a conseguire la parità di genere, sicuramente l’economia complessiva e la società ne trarrebbero enormi benefici.